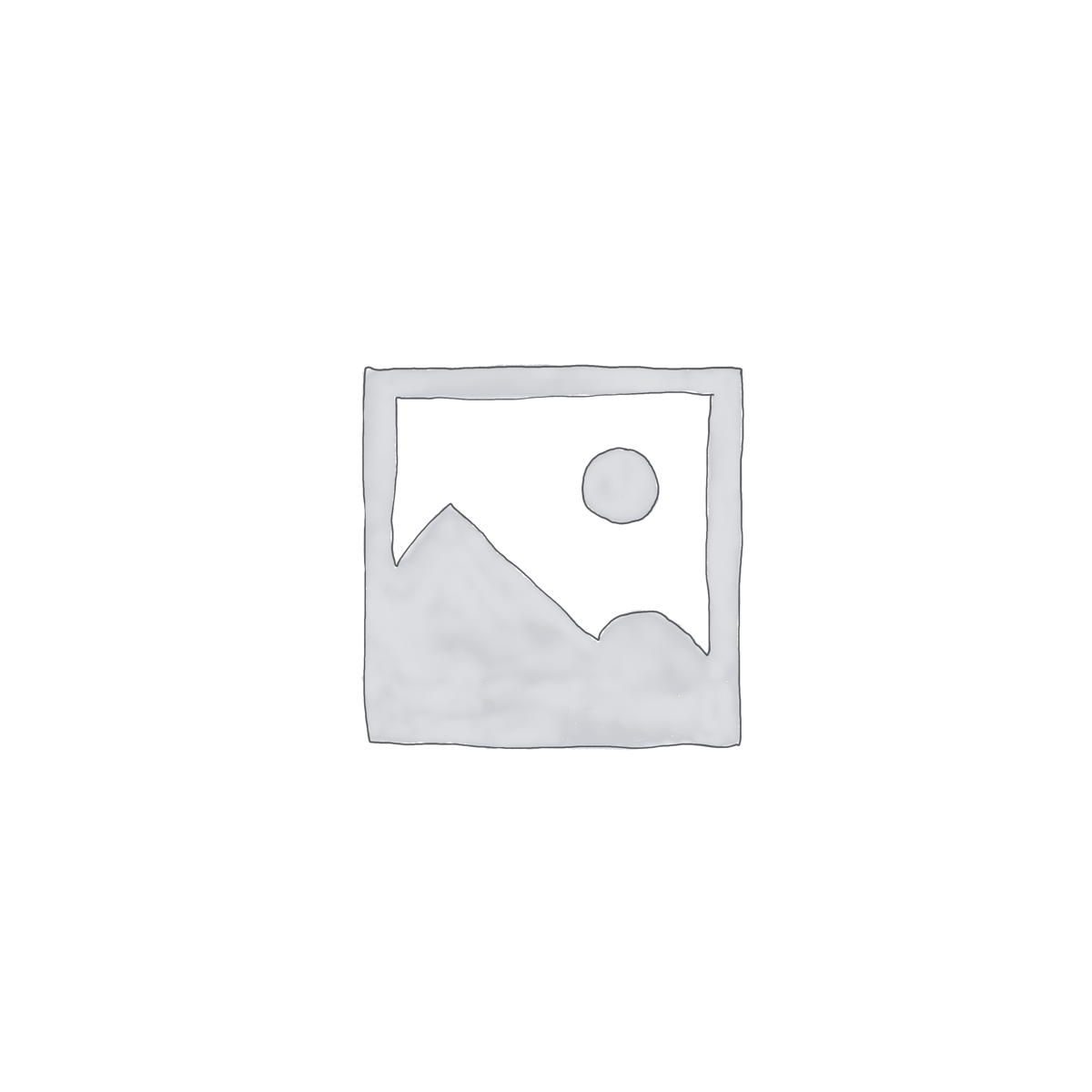Ceramiche di Seminara
La ceramica di Seminara è famosa in tutto il mondo. Le sue origini ci portano indietro nel tempo di molti secoli sebbene non si sappia con certezza quando la lavorazione della ceramica per fini artistici e decorativi sia diventata la principale attività del piccolo Borgo calabrese.
Per certo sappiamo che nel 1746 risultano presenti almeno 23 botteghe di ceramica. Nel 1777 il viaggiatore inglese Henry Swinburne, di passaggio a Seminara, scriverà di “un fermento di botteghe ceramiche”. Nel ‘700 infatti Seminara è famosa per la sua ceramica al pari di Caltagirone in Sicilia. Il disastroso terremoto del 1783 rase al suolo il paese. Uno dei più nobili e ricchi borghi del reggino fu praticamente cancellato e con esso la sua arte e la sua cultura.


Le conoscenze odierne sulla ceramica seminarese risalgono a manufatti dell’ ‘800 (i più antichi che si conservano). Ma è presumibile che le tipologie attestate in quel secolo ripetano forme, tecniche di invetriatura e decorazioni dei secoli precedenti. Purtroppo il terremoto del 1783 che rase al suolo il paese di Seminara ha lasciato un enorme vuoto nella ricostruzione storica di questa antica tradizione. Nel 2019 è stato inaugurato il moderno Museo della Ceramica di Seminara che ripercorre la storia di questa antica tradizione.
A Seminara, in provincia di Reggio Calabria, si producono ancora oggi artigianalmente delle maschere dall’aspetto grottesco che si rifanno anche alla tradizione greca e che fin dal passato avevano lo scopo di tenere lontano gli spiriti del male e che vengono poste all’interno delle abitazioni o sui tetti delle case.
Tra le maschere tipiche c’è anche quella raffigurante un satiro portatore di positività, spesso oggetto di regalo perché beneaugurante e in più perché rappresenta un esempio tipico fatto a mano della splendida ceramica di Seminara.

La Filatrice
Nelle loro botteghe, autentici laboratori di arte e genialità, gli artigiani ruotavano in un microcosmo fatto di leggende, folklore, ombre, pensieri, sacrifici e tradizioni, che essi tramandavano di padre in figlio, come preziosi e permanenti ideali.
Era una donna che trasformava una massa informe di batuffoli di lana in un filo da lavorare, al fine di ricavarne coperte, maglie, mutande, calze, ecc. Aveva un’ottima preparazione manuale, spesso tramandata da madre in figlia, e dedicava all’attività del filare gran parte della sua giornata. Soprattutto nei periodi di carestia e di guerra, filava davanti al focolare fino a notte tardi.


Spesso provvedeva prima a scucire i vecchi indumenti in maglia ormai inservibili, e poi utilizzava quei fili di lana per fare dei nuovi indumenti necessari al mantenimento decoroso della sua famiglia. Il fuso era costituito da un fusto di varia forma un centimetro di diametro ed una lunghezza di circa 30 cm recante nella punta superiore un piccolo ingrossamento cocca al quale si fissava il filo che usciva dalla Conocchia. Era generalmente di legno, come attestato da numerosi ritrovamenti in molte tombe dell’Antico Egitto. La Conocchia o Rocca era lo strumento sul quale la filatrice disponeva il materiale per averlo sempre a portata di mano.
La struttura era costituita da un bastone di legno con una gabbietta posizionata in alto nella quale si metteva la massa del filato. Prima di arrivare al fuso, la lana doveva passare una lunga trafila. La lana, prima fibra tessile utilizzata dall’uomo, veniva lavava più volte, la si faceva asciugare a lungo prima di passare alla cardatura. Queste operazioni erano necessarie per liberarla dalle impurità. La cardatura veniva fatta esclusivamente a mano con i suoi cosiddetti cardaci: due asticelle di legno dotate di impugnatura irta di chiodi la fregatura di uno contro l’altra con in mezzo alla massa di fibre provvedeva a districare le fibre stesse. Quando finalmente la lana era diventata gonfia e soffice, allora poteva essere utilizzata.

Pipa artigianale
I folti boschi delle Serre calabresi hanno una storia affascinante da raccontare. La storia di una tradizione che racchiude l’eleganza del legno, il pregio di un’opera d’arte ed il profumo del tabacco. La tradizione legata alla produzione di pipe artigianali che i pastori cominciarono ad intagliare, assieme ad attrezzi ed utensili di uso quotidiano, nelle lunghe ore di attesa a guardia delle greggi, sfruttando l’abbondante legname della zona.
Quello delle Serre calabresi è un territorio ricco di risorse agricole e forestali che offrono una materia prima dalle caratteristiche uniche e le pipe calabresi, infatti, oltre ad essere apprezzate per il pregio della loro lavorazione, si distinguono per l’ottimo sapore che sprigionano quando le si fuma, meno aspro ed amaro di quello di altre pipe. Il segreto che si cela dietro a questo sapore gradevole è legato proprio al legno da cui vengono ricavate che presenta un basso contenuto di tannini, responsabili delle note agre che si percepiscono fumando altre pipe.


È la radica calabrese, ossia l’Erica Arborea, che da queste parti viene chiamata “ciocco”, a donare la materia prima per la realizzazione di questi piccoli capolavori. In particolare viene utilizzata una protuberanza della radice proprio alla base del fusto. I “cioccaioli”, che si occupano di cercare e prelevare la radica sulle alture delle Serre dello Zomaro e in Aspromonte, una volta estirpate a mano le radici, le consegnano agli artigiani che selezionano i pezzi più pregiati per trasformarli in placche che vengono bollite in caldaie di rame per eliminare il tannino e poi fatte riposare per garantire un processo di essiccazione naturale. Quando il materiale è ancora umido comincia la lavorazione. E’ con la stagionatura, che dura fino a cinque anni, che si formano le caratteristiche venature tipiche della radica. Si tratta, dunque, di un procedimento lungo e complesso che richiede una particolare abilità dell’artigiano e che contribuisce a conferire ulteriore pregio alla lavorazione.